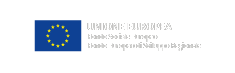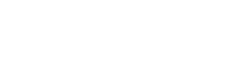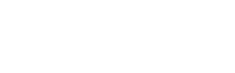Con un linguaggio non canonico, prospettive non convenzionali e uno sguardo originale, Fabio Rugge esplora la Città Media, il cui esordio ufficiale è collocato nel primo annale dell’Imperial Ufficio Statistico tedesco (1880) che compie per la prima volta una distinzione tra città grande, media e piccola.
Ripercorrendo il mutamento del sostrato sostanziale della città e la sua stessa natura, da “città dei cittadini” (comunità) a “città degli abitanti” (agglomerazione abitativa), a “città dei clienti” (fruitori di servizi), l’autore affida alla Città Media il compito di produrre una nuova stagione della civitas preservando il proprio ruolo di presidio della diversità rispetto allo sviluppo di città globali tendenti all’omologazione.
È nella Città Media, infatti, che si ritrovano ancora quei caratteri di “costituzione comunitaria” e “società conviviale” che, a partire dalla integrazione della persona con la collettività, rendono possibile una segregazione residenziale contenuta, buona coesione sociale, partecipazione e vicinanza tra cittadini e vertici territoriali, equilibrio territoriale e impresa innovativa. Condizioni tutte che fanno oggi della Città Media l’erede di quella costituzione interna peculiare della città millenaria europea e specificamente italiana.
Fabio Rugge è stato Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, presso la quale è professore emerito di Storia delle istituzioni politiche. Ha presieduto la Fondazione Romagnosi – Scuola di Governo locale che ha contribuito a fondare. È stato fellow presso la Technische Universitaet di Berlino, il Nuffield College di Oxford e il Woodrow Wilson Center di Washington D.C. È stato membro dell’esecutivo dell’International Social Science Council e ha coordinato il Working Group “History of Public Administration” dell’International Institute of Administrative Sciences di Bruxelles. Tra le sue pubblicazioni legate al tema della città: Il governo delle città prussiane tra Ottocento e Novecento, Giuffrè 1989; I regimi delle città. Il governo municipale in Europa tra ‘800 e ‘900, Angeli 1992; Per uno studio della municipalizzazione nell’età della ricostruzione, in Le autonomie locali, Rubettino 2010.
Questo documento riproduce il testo di una lectio magistralis tenuta all’Università di Pavia su invito della Fondazione Giandomenico Romagnosi, il giorno 8 luglio di quest’anno.
Le “Città Medie”- Un certain regard
1. Un certo sguardo
“Un certain regard” è – come si sa – il titolo di quella sezione del festival di Cannes che accoglie opere prodotte con linguaggio non canonico. Ho scelto, a mia volta, questo titolo, perché parlando di “città medie”, ho scelto un tema che altri potrebbero svolgere con ben maggiore competenza. L’ho fatto tuttavia con l’intenzione di proporre uno sguardo – un certain regard, appunto – non canonico e prospettive non del tutto convenzionali. Spero che sia lo sguardo che le prospettive possano, in qualche misura, risultare utili.
2. Gli sguardi che creano territori (la “biglia blu”)
Faccio solo una premessa. La discussione che condurrò appartiene a quel genere di discorsi con i quali le donne e gli uomini ‘creano’ territori. Sono discorsi svolti nel linguaggio e con le categorie dell’architettura e del diritto, della sociologia e della statistica, per non parlare della storia e della biologia e hanno l’aria di descrivere e raccontare i territori, ma in realtà, in qualche modo, li producono, li chiamano in essere. Attraverso tabelle statistiche, narrazioni storiche, provvedimenti legislativi, messaggi pubblicitari, mappature commerciali e biotopiche, progettazione di servizi sociali si costruiscono modi di guardare i territori che sono tutt’altro che anodini.
C’è una foto, per esempio, che è stata definita la “biglia blu” e rappresenta non la prima, ma sicuramente la più suggestiva immagine della Terra ripresa dallo spazio. La scattarono tre astronauti americani nel 1972. Credo che questo scatto abbia globalizzato il mondo non meno che la diffusione delle merci, il trasferimento delle imprese, i flussi migratori, la diffusione delle epidemie, il traffico turistico. Ha reso infatti chiara a tutti, a colpo d’occhio e imperiosamente, la nostra appartenenza a un’entità unica e la circostanza perciò che il destino di un luogo implica quello degli altri. Ha reso anche plasticamente chiara la possibilità materiale che da ogni punto della sfera un altro punto qualsiasi possa essere raggiunto a patto di ignorare ciò che dallo spazio non risulta: l’esistenza dei confini.
Dalla “biglia blu” non risultano, del resto, né città capitali, né stati, né i “territori indigeni” brasiliani o le “riserve indiane” statunitensi, né le “aree di libero scambio” né le prefetture e le contee. Anche qui, si tratta di un certain regard sul mondo: un altro di quelli che studiosi di governo del territorio non dovrebbero mai trascurare. Ed è a questo ordine di sguardi che appartiene anche quello che riguarda le “città medie”.
3. Le “città medie” – variazioni storiche
Ora, però, di cosa parliamo, cosa suggeriamo ed evochiamo (o creiamo) quando discutiamo di “città media”? Apriamo qui un capitolo, noto ai più, ma dal quale non possiamo prescindere: quello concernente la definizione del nostro oggetto.
A proposito della quale vi è subito da ripetere una constatazione quasi ovvia: la nozione di “città media” è altamente sensibile al contesto. In altri termini, dipende fortemente dalla cultura temporale e geografica in cui è impiegata. Se adoperiamo, a esempio, una metrica demografica (quella più frequente e più influente), possiamo facilmente convenire che una “città media” è una centro urbano con un numero di abitanti né troppo grande né troppo piccolo. Ma, se poi ci spingiamo più in là, si dischiudono le porte del relativismo.
Prendiamo, per esempio, le classi di città create rispettivamente dagli statistici francesi di metà Ottocento e da quelli di oggi. Ebbene, la classificazione proposta da questi tecnici è, nell’arco di un secolo e mezzo, significativamente mutata. All’attuale sguardo statistico può risultare “città media” un centro di 150.000 abitanti, che per i demografi del XIX secolo erano largamente sufficienti a includere una città tra le grandi. Dunque, la nozione demografica di città media cambia nel tempo.
4. Le “città medie” – variazioni geografiche
Quella nozione però cambia anche nello spazio. Ripeto qui osservazioni su cui gli esperti non mancano mai di insistere; e lo faccio solo con qualche esempio.
Nella letteratura riguardante il caso indiano, si intende che appartengano alla categoria che ci interessa i centri con popolazione compresa tra 100.000 e un milione di unità; e non troppo differente è la scala accolta in Argentina (50.000-1.000.0000). Per contro, in uno studio dello stesso anno (2013) riguardante l’Inghilterra, sono considerate “mid-sized cities” quelle con popolazione compresa tra 250.000 e mezzo milione di abitanti. Un anno dopo, nel 2014, il governo cinese ha, da parte sua, adottato una nuova classificazione delle realtà urbane del paese. In base a questa, per collocarsi tra le “città medie” un centro deve contare almeno 500.000 abitanti, un livello minimo che costituisce invece il ‘soffitto’ della categoria nel Regno unito. Del resto, le autorità cinesi pongono il limite superiore di popolazione di una “città media” 6-7 volte più in alto di quanto fanno, per esempio, gli studiosi dell’Insee francese. Questi, in una nota del 2017, pacificamente stabiliscono che una “ville moyenne” è un ‘polo’ che, possiede sì ulteriori caratteristiche economico-sociali e amministrative, ma comunque non eccede il 150.000 abitanti.
Ora, questa estrema variabilità dovrebbe sconsigliare ardite comparazioni internazionali. Di solito, si esce infatti da questi esercizi comparativi con un concetto di “città media” così dilatato da risultare sostanzialmente inutilizzabile. Ecco, perché nel prosieguo del mio discorso mi atterrò a una concettualizzazione aderente alla realtà europea. Non si tratta, evidentemente, di etnocentrismo, ma, al contrario di un po’ di rigore analitico e soprattutto di rispetto per la peculiarità storica del nostro continente.
5. 1880: nascono le “città medie”
Trattando di storia e tornando ai numeri, dobbiamo comunque concedere che lo sguardo statistico-demografico, con tutta la sua variabilità, è stato il primo a mettere a fuoco il concetto di “città media”.
Alcuni sostengono che lo fece – sia pure implicitamente – durante il convegno statistico internazionale convocato a Roma nel 1887. Nel pieno di un forte dinamica di inurbamento e di urbanizzazione che andava investendo tutta l’Europa, l’ungherese Kőrösi József, propose con successo, in quella circostanza, la distinzione tra “città” e “grandi città”. Le prime dovevano possedere almeno 20.000 abitanti, le seconde dovevano superare la soglia dei 100.000. Certamente, parlare di “grandi città” implica logicamente postulare l’esistenza di quelle medie e piccole, ma – se si vuole essere precisi – bisogna pur sottolineare che, nella circostanza in questione, la locuzione “città medie” non fu pronunciata.
Se invece si consulta il primo annale dell’Imperial Ufficio Statistico tedesco, uscito nel 1880, si trova esplicitata una categorizzazione delle città in “grandi” (con oltre 100.000 abitanti), “medie” (con oltre 20.000) e piccole (con oltre 5.000). Collocherei perciò qui l’esordio ufficiale del concetto di “città media”. E tuttavia a proposito di statistica tedesca, c’è un reperto interessante che vorrei proporre ed è tratto da una pubblicazione dell’Ufficio statistico tedesco, risalente a molti anni più tardi, al 1940 e intitolata “Città e campagna nel Reich tedesco”.
6. Un’icona della “città media”
Si tratta di una vignetta contenuta in quella pubblicazione. Serviva a evidenziare come, nei precedenti settanta anni, si fosse evoluto, in Germania, il rapporto tra le quote di popolazione residente rispettivamente in campagna, nelle città piccolo-medie, e nelle grandi città. Non sono queste quote però che ora ci interessano, quanto piuttosto la rappresentazione iconografica delle differenze tra queste tre categorie.
Nella vignetta, l’immagine della grande città mostra, sullo sfondo di una serie di condomini a più piani, nient’altro che un’automobile, un tranvai e un autobus. La città media e piccola, da parte sua, non sembra aver bisogno di alcun mezzo di trasporto ed esibisce, oltre a uno scenario di case dal tetto spiovente, un paio di alberelli (di cui non c’è traccia invece nella rappresentazione delle grandi città). Si noteranno però soprattutto, collocati al centro dell’immagine, una chiesa e il suo campanile.
Non voglio sottoporre questa illustrazione a un eccesso di esegesi. Credo tuttavia che alcune cose vi si possano leggere. La tipica forma della grande città contempla, a esempio, una contrazione e un’atomizzazione dello spazio abitato e, correlata, la centralità del mezzo di trasporto pubblico o privato. Queste due circostanze evocano manifestamente un motivo che oggi definiremo di “qualità della vita”. Lo stesso motivo, d’altronde, riemerge, rovesciato, nel quasi idillio delle città medie e piccole, che lasciano spazio al verde e, con la chiesa, a una dimensione insieme spirituale e comunitaria. Ma, lasciamo l’iconografia e torniamo al nostro sguardo classificatorio.
7. Oltre la demografia
Evidentemente, le soglie di popolazione non sono le sole attraverso le quali si è proceduto a identificare le città medie.
A esempio, uno studio di Anci–Ifel, risalente ormai a una decina di anni fa, ha scelto la via di un mix di criteri: un minimo di 45.000 abitanti, la specializzazione nel settore secondario o terziario, la qualità di “poli urbani” intesi come centri di offerta di alcuni servizi essenziali. Alle 94 città così censite sono stati aggiunti i capoluoghi di provincia e sottratte le quattordici città definite, dall’ordinamento italiano, come “metropolitane”. Ne è risultata una tabella che circoscrive un insieme di realtà dotate di una certa omogeneità e di una buona caratterizzazione rispetto a un universo urbano ben più ampio.
Non è difficile tuttavia rilevare che questo insieme include casi assai differenti, sotto diversi profili. Annovera, per fare un esempio, il comune di Lecce e quello di Padova, sebbene il primo abbia una popolazione pari a meno della metà di quella di Padova e contasse, nel 2016, un numero di contribuenti con reddito superiore ai 120.000 euro che era pari a meno di un quarto di quello registrato nel capoluogo veneto.
Questi scarti, sicuramente accettabili nella costruzione di un idealtipo, ci dicono tuttavia che non sarebbe superfluo mettersi alla ricerca di altri fattori costitutivi della idealtipica “città media”. Ma, in quale ulteriore direzione ricercare il principio di un’identità per dir così ‘medio-cittadina’?
8. La città di Max Weber e il suo destino
Riflettendo a questo interrogativo, non è certo inutile ripescare il celebre capitolo che Max Weber dedica alla città nella sua “Wirtschaft und Gesellschaft”. Lo studioso tedesco vi stabilisce alcuni tratti di quella città a carattere comunale (Stadtgemeinde) che – a suo dire – “solo l’Occidente ha conosciuto” (e ritorna qui il motivo, già richiamato, del contesto culturale!).
I tratti della Stadtgemeinde sono questi cinque: la fortificazione (quindi una cinta muraria), il mercato, una giurisdizione e un ordinamento propri, il carattere associativo (Verbandscharakter) e, infine, una certa autonomia e una certa autarchia, nel senso di un’amministrazione attraverso autorità alla cui nomina partecipano, in qualche maniera, “i cittadini in quanto tali”. Weber ricostruisce come all’origine di tale realtà vi fosse la coniuratio, una solidarietà giurata, spesso qualificata come “fratellanza”. La città, insomma, era costruita attorno a un ceto, cioè a una categoria di persone accomunate da una posizione sociale comparabile, da interessi economici di egual tipo e da una visione del mondo condivisa. Questo ceto dava il tenore alla vita cittadina ne costitutiva e ne custodiva lo spirito. Cosa è stato, nel corso del tempo, di questa città che potremmo definire cetual-comunitaria o “dei cittadini”?
In effetti, quella che era già in incipiente ai tempi di Weber è una storia per un verso di trasformazione, per altro verso di declino della città comunitaria e ‘compatta’ ipostatizzata dal grande studioso.
Chi dà speciale credito agli aspetti spaziali, vedrà un primo episodio di quel declino nella falcidie delle mura che, da Dresda a Torino, accompagnò l’epopea napoleonica. Altri registreranno la progressiva forzosa riconduzione del termine “cittadino” allo stato piuttosto che alla città: l’eclisse quindi di una cittadinanza legata a una comunità vicina e palpabile a favore di quella legata a una comunità statal-nazionale distante e virtuale. Nel 1983 Benedict Anderson avrebbe definita la comunità nazionale una comunità “immaginata”, ma già Vincenzo Cuoco l’aveva qualificata, più di 180 anni prima, una cittadinanza “chimerica”.
9. La crisi della città comunitaria: Eliot e Forsthoff
Tuttavia, la crisi della città cetual-comunitaria si consuma pienamente solo nel 20° secolo. Più che attraverso dati demografici o urbanistici, vorrei documentarla attraverso due testimonianze del tutto coeve e, al tempo stesso, profondamente diverse: l’una di un poeta, l’altra di un giurista. Il poeta è Thomas Stearn Eliot, il celebrato autore di “The Waste Land”. Nel 1934, Eliot fa recitare a un suo coro queste parole: “Quando lo straniero dirà: «Che significato ha questa città? Vi tenete stretti l’un l’altro perché vi amate?», cosa gli risponderete? «Abitiamo vicini per cavar denaro l’uno dall’altro» oppure direte: «Questa è una comunità»?”.
Qui è chiaro che la concezione comunitaria della città, quale abbiamo visto rappresentata in Weber, sta conoscendo una crisi profonda. Una comunità che era, almeno in parte, titolare di un nomos, di una sua legge, diviene il luogo della anomia.
Siamo, con il coro di Eliot, nel 1934. Due anni prima era stato però pubblicato in Germania il libro di un importante giurista, Ernst Forsthoff. Lo studioso vi constata l’avvenuta transizione dallo Stadtgemeinde, il comune dei cittadini, coincidente con la città storica, all’ Einwhonergemeinde, il comune degli abitanti. È mutato – sostiene Forsthoff – quello che egli chiama il “sostrato sostanziale” del municipio. Ora, esso “non è più – cito – una piena comunità territoriale, capace all’occorrenza di superare in sé stessa ogni altra tensione sociale”.
Qualche decennio dopo, mentre il Ventesimo secolo si esaurisce, la città degli abitanti diventerà addirittura, con l’avvento del new public management, la città dei clienti. Il popolo urbano sarà concepito come la platea dei fruitori di quelle utilies che invece, per una breve stagione della città comunitaria, erano state, grazie alla municipalizzazione, proprietà del comune stesso e, almeno virtualmente, dei suoi cittadini.
10. La città è morta, regna l’urbano
In verità, ben prima dell’esordio del new public management, la consapevolezza della mutazione profonda della città storica si era espressa in un’altra parola d’ordine: la morte della città. Pronunzia questa sentenza Georges Lefebvre nel 1970. La riprenderà qualche anno dopo Francoise Choay, proclamando l’avvento del regno dell’urbano. Questo ‘urbano’ “appare e si manifesta – scrive Lefebvre – nel corso dell’esplosione della città”. L’urbano è – secondo quanto chiarirà, a sua volta, Choay – la forma di civiltà generata dal distendersi della città nella campagna e la sovrapposizione, a livello planetario, delle due.
Si esplicita e consuma così la dissociazione tra due nozioni che, in realtà, erano già state individuate da pensatori della classicità e dell’alto medioevo, come Cicerone o Agostino ed erano state poi riprese alle soglie della modernità da Marsilio Ficino. Parlo della dissociazione tra urbs e civitas, dove la prima è una mera agglomerazione abitativa, estesa a piacere, la seconda una comunità dei cittadini, legata da vincoli organici a carattere politico e sociale.
11. Facciamo il punto
È ora tuttavia di formulare qualche riflessione più generale su quanto detto sin qui e di sollevare, ancora una volta, una questione di sguardo. Perché questa distinzione tra urbs e civitas è ancora importante all’inizio del XXI secolo? Perché la nozione di città comunitaria di Weber deve attirare la nostra attenzione? Perché, l’avvicendamento tra “città dei cittadini” e “città degli abitanti” così acutamente avvertito e fraseggiato da poeti e giuristi a metà del ‘900, riveste significato anche per noi che ci interroghiamo sulla natura e il destino delle “città medie”?
In sintesi, perché io credo che proprio alle “città medie” sia data oggi l’opportunità di rappresentare, in un nuovo contesto, la continuità dell’esperienza millenaria della città.
12. Città vs metropoli: di lessico e di idealtipi
Desidero infatti sostenere che la città non è affatto morta, come frettolosamente diagnosticato nella seconda metà del Novecento. Ma neppure ritengo plausibile affermare che essa sopravviva o riviva attraverso le forme assunte dall’urbano nelle metropoli e nelle megalopoli, cui di preferenza si è rivolta l’attenzione degli studiosi e dell’opinione pubblica dalla fine del XX secolo in avanti.
La città di contesto europeo ha rappresentato un fenomeno con precisi connotati sociali, politici, architettonici, economici, demografici, urbanistici. Questa città e il suo idealtipo non si può plausibilmente affermare che riviva in metropoli che contemplano molti milioni di abitanti, un’omologazione tendenzialmente transnazionale degli stili di vita, forme di marcata segregazione sociale, un’evidente dispersione nel contesto territoriale, ritmi elevatissimi di incremento della popolazione.
Al contrario, è proprio questa confusione che si fa e si perpetua, al ripario di un’inerzia lessicale dannosa alla distinzione e perciò alla comprensione. Si è sostenuto così che la città è morta o si sostiene al contrario che la città è viva, anzi vivissima; ma sempre fissando lo sguardo su ciò che – in molti sensi – non è più “città” ossia sulle forme dell’iperbole urbana, rappresentate adesso come destino dell’umanità, come un nuovo stadio della civilizzazione.
In questa prospettiva, le “città medie” non sarebbero altro che formati ridotti e incompiuti dell’urbano venturo. In quanto tali, si collocherebbero ai margini del percorso storico, residui destinati a trasmutare o a perire. A differenza delle metropoli, infatti, non risulterebbero appieno integrate nei circuiti dell’economia globale, resterebbero escluse dal giro degli attori politici e finanziari influenti, non presenterebbero quella densità di patrimoni immobiliari, di sedi di società multinazionali, di eventi culturali che fa delle grandi agglomerazioni urbane il luogo geometrico dei “vincenti”.
13. Le prestazioni delle città medie
Questa sottovalutazione delle “città medie” è obbiettivamente giustificata o è frutto di un pregiudizio storicistico che assegna prevalenza alle evenienze emergenti e considera le continuità come residui destinati alla marginalizzazione? In effetti, è molto probabile che questa seconda sia la risposta corretta.
È vero che secondo stime recenti, a livello globale, i centri (o FUA, functional urban areas) con popolazione tra i 50.000 e i 250.000 abitanti conosceranno, nei prossimi decenni, un incremento demografico modestissimo, a fronte del 46% pronosticato al termine delle prossime tre decadi per i centri tra 1 e 5 milioni di abitanti. Ciò non toglie che, stando a dati OECD riferiti al 2014, oltre un terzo, il 34,6% della popolazione di 31 Paesi considerati abitava in città con popolazione compresa tra le 50.000 e le 500.000 unità. Per l’Europa, adoperando criteri differenti, ma solo parzialmente divergenti, Eurostat calcola nel 2018 che in Italia la percentuale di popolazione presente in centri intermedi tra la grande città e l’area rurale raggiunge il 41% della popolazione totale. È interessante rilevare che una quota altrettanto alta, si ha, tra i grandi Paesi europei, solo in Germania (il 40%), altro stato caratterizzato da un’armatura urbana policentrica e da una persistenza della città storica.
Anche le performance economiche delle “città medie” non sembrano conclusivamente mostrare – soprattutto in casi nazionali caratterizzati da policentrismo – l’univoca tendenza al declino che l’hype metropolitano sembra pronosticare per loro. Da una recente ricerca di Roberto Camagni riguardante il caso italiano, apprendiamo che molte città medie hanno realizzato, nel periodo 2000-2019, crescite interessanti, anche se misurate sull’asticella piuttosto alta posta dal caso milanese (il quale, peraltro, si presenta di gran lunga superiore a quello di altre città riconosciute dall’ordinamento come “metropolitane”).
14. La sostenibilità– per esempio, i trasporti
Oltre a quello della crescita, un altro punto di vista da cui guardare alle “città medie” è quello della sostenibilità e, in particolare, della mobilità urbana.
È vero che il trasporto collettivo vi risulta (vorrei dire: ancora) piuttosto debole, raggiungendo percentuali del traporto locale intorno al 10-15%, ma scendendo talvolta sino al 5-8%. Tuttavia, si registra in questo tipo di centri una percentuale significativa di mobilità attiva: a piedi e – soprattutto in alcuni centri settentrionali – in bicicletta. Si tratta di una modalità di spostamento che recenti inchieste (per esempio, a Parigi) hanno visto apprezzata non solo in quanto ‘economica’ rispetto alle risorse ambientali e di tempo, ma addirittura – ed è il tratto curioso – in quanto segno di distinzione sociale, rispetto, in particolare, ai ‘dannati’ del metrò. E d’altronde, se si guarda ai Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) delle città medie italiane, ci si rende conto della ricchezza di prospettive e soluzioni alle questioni della mobilità rese possibili dal tessuto materiale e sociale di quelle città.
Altri ancora potrebbe osservare come la “città media” offra lo scenario più ovvio per politiche urbane tese a raccogliere e ad accogliere quella classe creativa di cui ha parlato in studi ormai celebri Richard Florida. E ancora, allargando lo sguardo alla dimensione regionale, si potrebbe ricordare il ruolo delle “città medie” nel riequilibrio e nella compensazione delle dinamiche imposte ai territori dallo sviluppo dei centri metropolitani.
15. Il fattore comunitario: materialità dell’immateriale
Non voglio però continuare questo ragionamento in forme retoriche che potrebbero farlo assomigliare a una gara tra “grandi città” e “città medie”. Vorrei piuttosto ritornare a un terreno su cui non c’è ragione di competizioni, ma solo espressione di costituzioni e vocazioni diverse.
La verità, infatti, è che il più netto criterio di distinzione tra i due idealtipi urbani che stiamo considerando risiede nell’aspetto che con queste riflessioni ho, sopra tutti gli altri, inteso sottolineare. Intendo dire che ciò che denota la “città media”, erede della città storica ovvero della “città dei cittadini” (contrapposta alla “città degli abitanti”) è ciò che definirei la sua costituzione comunitaria; una costituzione che tende a evaporare con l’affermarsi delle dinamiche di vario tipo che trasformano la città in metropoli.
Attenzione: non voglio suggerire un’idea sentimentale o ancestrale di “città media” (ciò che confermerebbe e legittimerebbe la sentenza storicistica che la condanna a un destino recessivo). Penso, al contrario, che una serie di elementi analitici possano confermare il valore concreto e incisivo di questo profilo comunitario apparentemente impalpabile.
Sulla scia degli studi concernenti il capitale sociale e la valorizzazione delle tradizioni civiche delle città italiane svolti, ormai trenta anni fa, da Robert David Putnam, può essere rinvenuto e riconosciuto il peso materiale di fattori che siamo abituati a denominare immateriali. Dagli studi organizzativi e topologici, peraltro, scaturisce la possibilità di misurare il significato della prossimità spaziale e sociale permessa e promessa dalle “città medie”. Penso agli studi condotti, già negli anni ‘60 dallo psicologo Stanley Milgran e suggestivamente soprannominati “teoria del mondo piccolo”. E penso alle suggestioni che più recentemente vengono dall’etnografia urbana – per esempio, dagli studi di Brigitta Schmidt-Lauber.
Ciò che apparenta queste teoriche è la possibilità di dare peso al grado di vicinanza tra le persone di un insieme – per esempio, degli abitanti di un centro urbano. Quanti passaggi sono necessari al cittadini di una “città media” per raggiungere attraverso contatti personali, effettivi e non virtuali, il sindaco della città? E quanto ‘centrale’ è ciascun cittadino rispetto a tutti gli altri in una “città media” se si confronta questa centralità con quella dell’abitante di una metropoli? Quale peso ha la frequenza degli incontri non programmati nella sedimentazioni di reti di reazionali creative?
16. Segregazioni
Sono schemi teorici che aiutano a rendere conto di dinamiche individuali. Ma queste dinamiche si ripresentano poi esaltate negli studi sociologici sulla frammentazione o segregazione riscontrabili nelle agglomerazioni metropolitane. In effetti, le ricerche su questi fenomeni di recinzione sociale sembrano concentrarsi – in Italia, ma non solo – sugli scenari metropolitani.
Non voglio sostenere – si badi – che la città pre-industriale, la città dei cittadini, con la sua tessitura comunitaria, fosse esente da forme di segregazione. La vicenda dei ghetti edificati nelle città italiane a partire dal 1500 sta lì a dimostrare il contrario. Non vi è dubbio, d’altra parte, che l’impennata della scala urbana, determinata dai fenomeni di urbanizzazione e migrazione, è stata quasi sempre un fattore di crescita di fenomeni di distanziamento sociale massiccio, marcato, perdurante. Né deve sfuggire che nella città storica certe segregazioni erano pur sempre figlie di una concezione organica della civitas. Sia che fossero imposte (come fu per gli ebrei) sia che fossero scelte (come fu spesso per altre nationes o per le corporazioni di mestiere), quei sottomultipli della comunità cittadina non ne negavano la configurazione unitaria e conchiusa – e di questa le autorità cittadine restavano padrone. Nella grande città i fenomeni distanziamento sociale si producono invece per effetto di processi incrementali, indotti da mano più o meno invisibili, che le politiche urbane rincorrono e solo faticosamente riescono a controllare (quando ci riescono).
17. La metropoli ha nostalgia della città
Del resto, il valore delle dinamiche partecipative è dimostrato, dai conati, coevi alla nascita della grande città, con cui questa ha tentato di galvanizzare un senso civico che i fattori della metropolizzazione minacciavano di spegnere. Mi riferisco alla vicenda del decentramento urbano; sulla quale è, ancora una volta possibile, uno sguardo diverso da quello convenzionale.
In Europa, quella vicenda si è svolta essenzialmente secondo due modalità. In taluni casi, è derivata dai processi di coalescenza attraverso cui piccoli centri minori si sono fusi attorno a un centro influente. Questo fu, tipicamente, il caso della Grande Berlino chiamata in vita da una legge del 1920. La nuova capitale amalgamò città come Charlottenburg, Wilmersdorf, Spandau in un’unità dieci volte più estesa della vecchia e due volte più popolosa; ma lasciò sopravvivere nelle unità amalgamate forme di self-government che contemplavano anche l’elezione del borgomastro (ed erano perciò dotate di un minimo dell’autonomia che Weber aveva individuato come essenziale alle città). In questa modalità, dunque, il decentramento è inteso a fare sopravvivere identità e comunità urbane precedenti che, per le ragioni più varie, non si vuole annegare nella realtà nata dall’agglomerazione.
In altri casi, in una seconda modalità, quella cui meglio conviene il descrittore “decentramento”, un soggetto istituzionale di grandi dimensioni territoriali e demografiche, comunque costituitosi, decide di riconoscere dignità istituzionale a suoi sottomultipli: quartieri, rioni, circoscrizioni, municipi. In questi casi, a sollecitare il processo sono essenzialmente due motivazioni, intrecciate, ma distinguibili. Da una parte, le unità di decentramento sono state ritenute utili a dislocare, avvicinandoli ai cittadini, attività e servizi di varia natura. Dall’altra parte, le unità sono state create col proposito esplicito di realizzare momenti di partecipazione. Questa motivazione è stata – per non fare che un esempio – la più sentita o comunque la più evocata nelle prime esperienze di decentramento circoscrizionale varate in Italia negli anni ’70.
E’ facile constatare come, in ogni caso, tendenze siffatte si siano instaurata quando il tessuto sociale delle grandi città ha cominciato a conoscere cedimenti e lacerazioni sotto la spinta di fattori demografici o di conflittualità sociale (o quando si è temuto che ciò potesse avvenire). Se questo è vero, i processi di decentramento urbano si presenterebbero come la creazione di arene istituzionali intese a restituire agli abitanti della grande città una dimensione cittadina smarrita e una soggettività di cittadini ormai diluita.
E forse dovrebbero essere intese nello stesso senso le politiche preconizzate dall’urbanista Carlos Moreno per riconvertire la metropoli parigina in una città dei quindici minuti, cioè in una configurazione urbana che renda accessibile ogni risorsa vitale (lavoro e sport, scuola e cure mediche, intrattenimento e shopping) nello spazio temporale di un quarto d’ora. Ascoltando Moreno lo sentirete affermare che due dei quattro pilastri della sua proposta sono la costruzione di nuovi legami tra le persone e l’attivazione di una vivace partecipazione costruttiva. Viene da pensare: che la metropoli abbia nostalgia della città? E non sono forse le città medie l’archetipo delle città dei quindici minuti così concepite?
18. La città (media) come città conviviale
Per avviarmi a concludere, vorrei servirmi di un ricordo personale. Molti anni fa, ebbi in sorte fortunata di incontrarmi e conversare a lungo con quel pensatore singolare e formidabile che fu Ivan Illich. Scomparso esattamente venti anni fa è oggi – mi pare a torto – scarsamente ricordato. Un giorno la nostra conversazione toccò il topos (anche pittorico) della torre di Babele, così spesso associata alla metropoli, per via della sua grandiosità, ma anche come scaturigine di frammentazione e alienazione. Fu in quella occasione che Illich (il cui pensiero purtroppo conoscevo allora assai poco), mi parlò della sua idea di “convivialità”.
Per chi abbia poca confidenza con questo autore, dirò che non si tratta solo, come farebbe pensare l’uso corrente della parola, di un anelito generico alla condivisione, alla cordialità e all’amicizia. Piuttosto, per Ilich una società conviviale è una “società in cui lo strumento moderno sia utilizzabile dalla persona integrata con la collettività, e non riservato a un corpo di specialisti che lo tiene sotto il proprio controllo”.
Ecco, penso alla “città media” come all’istanza di una società conviviale; un’istanza – un “dispositivo”, come direbbero alcuni colti strutturalisti – che sia strumento nelle mani dei cittadini, che si avvicini a loro con amicizia, che sia “moderno” senza spossessarli. Una città media fatta a questo modo potrebbe convivere con l’iperbole urbana provvedendole la diversità che la metropoli consuma, ma non produce, offrendole un bilanciamento territoriale indispensabile, suggerendole nuove modalità di azione collettiva e di partecipazione, proponendole paradigmi di coesione, integrandone l’impresa innovativa.
Certo, una simile “città media” non può limitarsi a rivendicare l’eredità della gloriosa città dei cittadini né tantomeno a contenderla alla metropoli (che d’intestarsi quel lascito non ha né il titolo, né i mezzi, né tantomeno l’intenzione). Troppi fattori sono intervenuti (in primis quello informatico/telematico) a mutare le condizioni spazio-temporali dell’aggregazione sociale. No, la “città media” – almeno quella italiana dell’inizio del XXI secolo – non è né la showcase di una ‘arcadia urbana’ irrimediabilmente persa, né un territorio al sicuro da scosse telluriche. Piuttosto può e deve a produrre una nuova stagione della civitas; una stagione in cui emergano chiaramente l’ambizione e la capacità non di rosicchiare alla civiltà metropolitana quote di hype and glamour e di farsene ricadere addosso i cascami, ma di dare un contributo originale alla civilizzazione europea in via di evoluzione.
19. Conclusioni e ipotesi
Ma è il momento ora di mettere a fuoco le conclusioni suggerite dal quel certo sguardo che ho cercato di proporre. Si tratta – attenzione – di conclusioni in parte ipotetiche, che scontano la necessità che il tipo della “città media” venga scolpito meglio, attraverso set di indicatori capaci di investire in modo sistematico, di questo tipo di centri, il tessuto sociale e politico, la ‘costituzione sociale’ (quello che è al cuore della mia riflessione).
La prima conclusione è, comunque, la necessità di prendere sul serio la cesura, consumatasi nel corso del Novecento tra città e metropoli. È a tutti chiaro che le “città medie” non sono metropoli mancate; ma bisogna anche comprendere che parlare di grandi città – e quindi, per converso di “città medie” – non aiuta a riconoscere il salto tipologico che la frattura novecentesca ha prodotto. Nasconde il fatto che ci troviamo davanti a due fenomeni, a due fenotipi in corso di differenziazione. Altrettanto fuorviante è la rinunzia a declinare come tipo specifico la “città media” italiana/europea.
La seconda conclusione è che la scala demografica è solo in parte efficace a distinguere tra i due fenotipi. Né questo criterio può essere individuato principalmente nelle relazioni tra il centro urbano e il territorio circostante (per esempio, fissando l’attenzione solo sulla natura di polo di un centro o sul suo rapporto con la “area vasta”). La città di tipo europeo – e specificamente italiana – è caratterizzata da una costituzione interna peculiare: da un tessuto di relazioni orizzontali e verticali che sussiste solo a certe condizioni: segregazione residenziale contenuta, buona coesione sociale, partecipazione e vicinanza tra cittadini e vertici istituzionali (non solo politici!), identificazione con spazi e simboli condivisi…
La terza conclusione è che queste condizioni, mediamente presenti nelle “città medie”, ne fanno le eredi della città storica ‘di forma europea’. Tuttavia, per assumere una tale eredità esse dovranno acquisire consapevolezza della loro specificità ‘costituzionale’ e lavorare a riprodurla e aggiornarla. Deve dunque essere alle viste una nuova “città media”, dalla tessitura smart, capace di lanciare collaborazioni reticolari estese, consapevole del proprio ruolo di presidio della diversità rispetto alla sviluppo di città globali tendenti all’omologazione. Una siffatta “città media” potrebbe rappresentare – almeno in Europa – il luogo vero e critico della ‘glocalizzazione’, intesa quale dialettica universale/particolare capace – come postula l’attualissimo manifesto glocalista di Piero Bassetti (2008) – di tenerci al riparo da “uniformità apolide, macdonaldizzazione, squilibri, ecodrammi”.