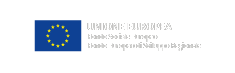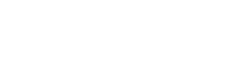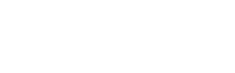Riflettendo sulla fine della città come luogo della produzione di merci e la sua riconfigurazione come luogo della circolazione e del consumo, e dissentendo da chi predica la fine della dimensione spaziale della città, l’autore pone al centro il tema della governabilità e della capacità dei territori di cercare e definire meccanismi e forme di governance e di governo. Offre una rappresentazione dello sviluppo territoriale contemporaneo, riposizionando la questione dell’urbanizzazione come processo multi-livello e multi-attore. Appronta una tipologia di città basata sulle tendenze in corso in Italia emergenti dalle ricerche su postmetropoli, regioni urbane e città medie, ribadendo la necessità di nuove agende politiche basate sulle specificità spaziali, place-based che riconoscano le diverse “personalità dei territori”.
Paolo Perulli è sociologo dell’economia. Ha insegnato nelle Università del Piemonte Orientale, Venezia, Cambridge (USA), Parigi, Lugano. Tra i suoi volumi recenti Nel 2050. Passaggio al Nuovo Mondo (Il Mulino, 2021), Il debito sovrano. La fase estrema del campitalismo (La Nave di Teseo, 2020), The Urban Contract (Routledge, 2017), Terra Mobile (Einaudi, 2014).
Produzione di territorio e governo urbano
La cornice concettuale
La produzione del territorio è vista dalla teoria classica riferita a fattori di produzione quali terra, lavoro, capitale. Il sistema capitalistico è analizzato come circuito di produzione di capitale per mezzo di capitale (merce-denaro-merce, denaro-merce-denaro). Il capitale ha quindi bisogno di creare continuamente più punti di scambio, a propagare la produzione basata sul capitale. La tendenza a creare il mercato mondiale è data immediatamente nel concetto stesso di capitale. Ne deriva come conseguenza una esplorazione completa della terra per scoprire sia oggetti utili nuovi, sia nuove proprietà utili dei vecchi, oppure le loro proprietà come materie prime ecc.; e uno sviluppo di un sistema sempre più ampio e globale di tipi di lavoro, di tipi di produzione, ai quali corrisponde un sistema sempre più ampliato e ricco di bisogni.
Su questo punto, ci sarebbe molto da dire riguardo alle possibilità/modalità del capitalismo dell’esplorazione completa della terra. Una prima questione potrebbe riguardare il tema del capitale fisso sociale, cioè gli investimenti in infrastrutture per la produzione e la circolazione delle merci. Sono essi il requisito fondamentale, e non la densità della popolazione di per sé. L’agglomerazione urbana non è la condizione di per sé sufficiente per la circolazione del capitale. Il ciclo produzione-circolazione rinvia necessariamente e ineluttabilmente alla circolazione (mobilità) delle merci, incluso il lavoro e il capitale (denaro), entro il vincolo di fissità della terra, che però l’investimento in capitale fisso sociale e varie forme di sovrastruttura ideologica ridefiniscono in “spazio-merce”. Quindi il modo di produzione capitalistico è fondamentalmente spazio di reti e flussi, sia nella fase della rivoluzione industriale che in quella del capitalismo globale (nelle diverse varianti).
Questo approccio ha portato a una critica radicale delle variabili con cui tradizionalmente si definisce la città (densità, dimensione, diversità), e di altre teorie basate sul popolamento e le sue conseguenze, ma fa emergere la contraddizione tra mobilità e sfera della riproduzione sociale che non può prescindere da un certo grado di fissità territoriale (come si dirà tra poco, a proposito di governo del territorio).
Già, d’altronde, la nascita della società in rete, annunciava la fine tendenziale della città come luogo della produzione di merci e la sua riconfigurazione come luogo della circolazione e del consumo.
Nel processo di sviluppo capitalistico il territorio concorre sotto forma di risorsa, e insieme si ripropone come insuperabile ostacolo. È la particolare caratteristica dei fattori terra, lavoro e denaro: ciascuno di essi è merce, ma una merce fittizia perché la terra è anche Natura, il lavoro è anche attributo dell’uomo, il denaro è anche potere d’acquisto. Se trattati come merci prodotte per la vendita, affidando al mercato l’unico elemento direttivo, il rischio è la demolizione della società.
Le tipologie della governance
Di qui l’importanza di quei meccanismi di ‘autodifesa della società’ che chiamiamo istituzioni, regole del gioco cui i giocatori, gli attori in campo, devono attenersi. Questa visione normativa delle istituzioni è stata rinnovata alla fine del Novecento. Le istituzioni sono state elaborate come ambiti di strutturazione e organizzazione della società nella specie di città (grandi, medie, piccole, in rete etc.) e di regioni urbane. I territori acquistano personalità, sostenendo forme di economia variamente inserite e perfino annidate nelle reti sociali delle società locali. Su questa base, le implicazioni di policy indicano-in polemica con una visione politica centralizzata, sia nazionale sia europea- la necessità di nuove agende politiche basate sulle specificità spaziali, place-based.
Questa visione di società è oggi sfidata da una lettura neoliberista che propone di rilanciare l’autoregolazione di un mercato piatto e illimitato sostanzialmente indifferente allo spazio. Si tratti di istituzioni di regolazione, di pianificazione, o di forme di ordine spontaneo e di autoregolazione, di partecipazione attiva della società civile alla gestione di beni comuni: sono tutti meccanismi di governo e di governance, forze e forme di governabilità con cui il capitalismo deve fare i conti. Per alcuni, gli istituzionalisti, si tratta di vincoli benefici. Per altri, i neoliberisti, si tratta invece di ostacoli al pieno dispiegamento delle libere forze di mercato.
Una radicale critica alle concezioni correnti della globalizzazione, che predicano la fine dello spazio, è venuta da chi ha elaborato una genealogia delle forme spaziali come forme sociali immunitarie: dalle arche alle mura, dai confini del mondo ai sistemi immunitari. Stiamo passando nell’evoluzione storica universale da società-container a società dalle pareti sottili (Sloterdijk, 2003).
Brenner (2004) ha elaborato il concetto di glocalizzazione come strategia spaziale dello stato post-keynesiano in chiave competitiva e neoliberista. I progetti spaziali dello stato includono sia la riconcentrazione territoriale che la selezione spaziale. Successivamente la coppia concettuale implosione/esplosione sembra indicare una estensione planetaria dell’urbanizzazione, i cui protagonisti sembrano essere meno che in passato gli stati nazionali, e più le azioni strategiche di attori economici globali (imprese globali, reti finanziarie, reti tecniche e funzionali). In questo quadro la stessa questione dell’urbanizzazione si riposiziona: meno come prodotto degli Stati nazionali, più come processo multi-livello e multi-attore. Attori economici e funzionali-tecnici, privi di controllo, in grado di subordinare a sé (e di agire in concorso con) gli Stati: si pensi allo sfruttamento di risorse naturali in ogni parte del globo, la costruzione di nuove infrastrutture per la connessione fisica e immateriale, e la stessa esplosione urbana in molte parti del pianeta
Oggi, l’uscita del capitalismo globalizzato dai contratti sociali nazionali rappresenta la principale sfida dell’epoca contemporanea. Ma la capacità dei territori di cercare e definire forme di governance non si esaurisce di fronte alla crisi delle forme di regolazione statali-nazionali.
Nelle tabelle che seguono, cercheremo di seguire alcune di queste processualità
Nella prima tabella presentiamo una concisa tipologia e morfologia dello sviluppo territoriale contemporaneo, ma con attenzione anche ai processi di lungo-lunghissimo periodo, mettendone in evidenza le problematiche della governance e le implicazioni di policy.
Nella seconda tabella presentiamo, invece, un tentativo di tipologia di città basata sulle tendenze in corso in Italia emergenti dalle ricerche su postmetropoli, regioni urbane e città medie.
| Processi urbani | Morfologia | Governance |
| 1. SVILUPPO URBANO CHRISTALLERIANO (luoghi gerarchici centrali) | CONCENTRAZIONE Territori in sviluppo (economico, geopolitico), dove si riscontrano nuovi ispessimenti localizzati di crescita e innovazione | PIANI STRATEGICI visioni guidate da regole pratiche condivise da attori pubblici e privati per governare processi di sviluppo delle metropoli e post-metropoli mediante accordi inter-istituzionali e multi-attore su base volontaria, city deals, contrats de ville, altri contratti urbani |
| 2. ORDINE/DISORDINE INSEDIATIVO (luoghi della distruzione creatrice, ordini spontanei) | DISPERSIONE Nebulose-conurbazioni dove si riscontrano esplosioni di urbanizzazioni discontinue, reti di città | ASSENZA DI GOVERNO sregolazione, tentativi falliti di disegno urbano, informalità dal basso |
| 3. ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI (luoghi-spazi di flussi, città-gateway, città-nodo) | CONNESSIONE Piattaforme (dove si riscontrano nuovi sistemi-guida di economie-territorio) Corridoi (dove si riscontrano flussi densi di persone, merci e informazioni) | GOVERNANCE FUNZIONALE, di rete, hubs § spokes sistemi funzionali di gestione e sviluppo di reti territoriali, logistiche e informatiche, governance di corridoio, interregionalità e transnazionalità urbane |
Nel lungo periodo… | ||
| POLICY MAKING MULTILEVEL GOVERNANCE | UNA MAPPA URBANA RELAZIONALE, INTERATTIVA E DINAMICA | VERSO IL CITY REGIONALISM, L’AGENDA URBANA COME UNA RETE DI ACCORDI INTER-URBANI, INTER-GOVERNATIVI E INTER-ATTORIALI |
| Territori | Morfologia | Casi |
| Città metropolitana | Un centro che ordina gerarchicamente uno spazio, una società ordinata spazialmente e autocontenuta, oggi tendenzialmente in crisi | Torino |
| Città densa | Un’elevata densità e porosità urbanistica, sociale e ‘morale’, una società con forti connotati di anomia e sregolazione | Napoli |
| Città periurbana | Una nebulosa intorno alla città centrale (hub), che tende ad assumere connotati autonomi e diventare il luogo della trasformazione sociale post-fordista | Milano Regione Urbana |
| Città satellite | Nuove centralità metropolitane e urbane risoltesi nella creazione di ‘fortilizi in territorio nemico’, una società in via di periferizzazione | Roma |
| Città bordo | Urbanizzazione ai margini, città diffusa, forte consumo di suolo e di risorse naturali, con città medie rilevanti | Padova-Treviso-Venezia (Patreve) Pavia |
| Città corridoio | Struttura reticolare lungo assi infrastrutturali e confini naturali, con città medie rilevanti | Milano-Bergamo-Brescia Milano-Novara-Torino Verona-Venezia Milano-Bologna Rimini-Pesaro Firenze-Pisa-Livorno Firenze-Arezzo-Roma |
| Città giardino e città villaggio | Bassa densità, alta qualità ambientale e organizzazione a ‘isola’, villaggi a tema, centri storici insulari | Aree interne di Sardegna, Piemonte, Puglia, Venezia centro storico |